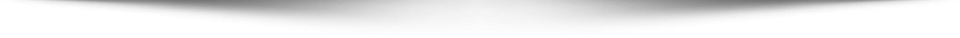L’invenzione del Reaedificetur Camerina.
Nonostante ignorassero le vicende dell’antica città, le genti vissute nel territorio circostante ebbero sempre la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un luogo magico, ricco di memorie e di tradizioni. Ma come si è passati dalla consapevolezza di vivere in un territorio cosparso di vestigia del passato, all’idea che Camarina, a distanza di più di venti secoli, avesse generato una nuova città? Come è nato il mito del riaedificetur[1] Camerina? Seguiamone quindi la nascita e lo sviluppo.
Riedificetur Camarina. Vittoria 360 anni di vita. Così Gian Giacomo Marino (1924-2006), giornalista, intitolò il suo discorso celebrativo nel salone della Pro Vittoria il 24 aprile 1967. I concetti espressi nella prolusione furono quelli basati sulle conoscenze storiche dell’epoca (Paternò-La China-Barone), arricchite dalle riflessioni personali dell’autore, nutrite anche degli stessi umori che la poesia di Francesco Maganuco (1907) e di Emanuele Mandarà aveva distillato e che leggiamo in una bella poesia di quest’ultimo, risalente al 1963. Nella riflessione di Marino è contenuto un concetto principale, che cioè Vittoria Colonna, fondando una nuova città, aveva messo ordine, aveva creato la vita lì dove prima «sensi di desolazione e di morte correvano lungo le rive dell’Ippari, per le rocce precipiti, dentro le cave grotte, tra gli agguati delle paludi…Nere serpi, nutrite dei miasmi di verdi acque stagnanti, si attorcevano nell’intrico della nemica boscaglia; e l’uomo…tornato Caino, attendeva nell’alta oscurità dei luoghi inospitali il suo Abele, per abbassare sul capo del fratello la mannaia della morte...». Sfondo più poetico difficilmente potrebbe immaginarsi. Si era trattato di «un’opera di bonifica morale e sociale, che riportasse gli uomini traviati nella norma e nella legge, e che nello stesso tempo riscattasse dall’abbandono millenario la selva di Boscopiano e condizioni civili a quanti si trapiantassero in essa, s’imponeva: un’opera di bonifica che fosse premessa di un’altra materiale ed economica…». L’eroina venuta a mutare questo “millenario abbandono” (che invece abbiamo constatato non esistere affatto) è appunto Vittoria Colonna. Anche Marino insiste sulla presenza del brigantaggio, come movente della fondazione e poi, dopo aver ricostruito i passaggi importanti (tra i quali la ricognizione di Paolo La Restia del 1604 per la scelta del luogo), della fondazione scrive: «Nel decreto di fondazione, firmato a Madrid il 24 aprile 1607…si legge infatti testualmente: “Riedificetur Camarina (sia riedificata Camarina)».
Senonché, avendo potuto leggere in maniera chiara e completa il testo del Privilegio (Raniolo 1990, Monello 1994-2007), in nessuna sua parte si legge una simile affermazione. Marino si fidò troppo delle sue fonti (Barone), né poteva fare altrimenti, per costruire la sua storia…
Altra prova per dimostrare l’eredità camarinese è stata cercata negli stemmi e soprattutto nella legenda del cartiglio tenuto tra gli artigli dell’aquila araldica e cioè “Victoria pulchra civitas post Camerinam”. Assertore di quest’altra teoria fu lo studioso Gianni Ferraro (1927-2002), il quale riferisce in una sua opera (cfr. Ferraro 1988) che sarebbe stato Giovanni Alfonso, in occasione della sua visita a Vittoria nel 1643 a dare alla cittadina il suo stemma: «un’aquila nera con sul petto un castello e tra gli artigli un nastro recante la scritta: Victoria, pulcra civitas post Camerinam».
Ma ciò avrebbe presupposto una conoscenza precisa della storia di Camarina da parte di Giovanni Alfonso, inoltre lo stemma scolpito sopra il portone dell’antica Madre Chiesa sembra escludere che ci fosse una lunga iscrizione e comunque non certo il post Camerinam presunto. Inoltre ancora nel 1748 l’appellativo di Vittoria è solo Pulchra Civitas, come ci testimonia l’iscrizione che si legge nel cartiglio tenuto tra gli artigli dell’aquila che allarga le sue grandi ali al centro della cassa dell’organo della Madre Chiesa, in cui si legge «eleemosynis populi pulc[h]rae civitatis Victorie». Lo stesso Amico, dopo aver enumerato le chiese e i conventi di Vittoria scrive: «né ai sacri edificii sottostanno il palazzo civile e molte case private, formando un assieme ben degno di ammirazione.
A ben ragione adunque fruisce la città.. del titolo di bella». Appunto pulchra in latino, mentre per quanto riguarda i grappoli d’uva, essi spuntano per la prima volta nel Teatro (quindi nel 1877) e nella chiesa di San Giovanni, in cui all’aquila sono unite le cornucopie da cui trabocca l’uva, che risalgono al 1886. Fino al 1764, la bella immagine di San Giovanni Battista, con sullo sfondo le città di Vittoria, che ricorda l’accordo con Chiaramonte sottoscritto il 7 marzo, giorno delle Ceneri, reca Victoria civitas e basta. Invece, in un timbro comunale risalente al 1818 si trova l’aggiunta post Camerinam (Ferraro, pag. 140). Pertanto la rivendicazione dell’eredità camarinese risalirebbe al periodo 1764-1818. Cosa accadde in quel periodo per far maturare quel concetto di “rinascita” di Camarina in Vittoria? Come e perché nacque il bisogno di dire che Vittoria era l’erede di Camerina? Quale fu il motivo urgente e necessario per rivendicare prima e vantare poi l’eredità camarinese e che, una volta affermatosi, divenne patrimonio della classe dirigente vittoriese a cavallo tra il Sette e l’Ottocento e si condensò nell’aggiunta all’epiteto tradizionale Victoria pulchra civitas delle parole post Camerinam. Dopo svariate ricerche, a poco a poco, sono arrivato alla conclusione che il post Camerinam fu frutto dell’esito felice della controversia tra Vittoria e Chiaramonte nel 1764. Quelle due semplici parole furono infatti l’emblema finale di una lotta, anzi di una “lite” giudiziaria, che in altri tempi avrebbe visto l’una contro l’altra armata e con grande spargimento di sangue le due città di Vittoria e Chiaramonte. Si trattò infatti di una controversia per lo “spazio vitale” e per la terra che scoppiò nel 1684 e nella sua fase finale occupò il ventennio dal 1744 al 1764.
Gli storici Paternò (1877) e La China (1890) trattano ampiamente tale questione dal punto di vista vittoriese (errate le date di Paternò, più corretto e assai informato La China, che poté leggere due documenti dell’Archivio di San Giovanni); padre Samuele Nicosia (1882, il più completo e preciso) e Corrado Melfi (1912) per Chiaramonte.
Paternò e La China accennano, anche se di sfuggita, al concetto del reaedificetur Camarina. Paternò, che con il latino doveva avere assai scarsa o addirittura nulla dimestichezza, scrive che per costruire Vittoria si disse: reidificatur Camerina, usando una forma sgrammaticata e inesistente di congiuntivo esortativo; La China, più colto e buon conoscitore del latino corregge «e poi si disse riaedificetur Camarina»: nessuno dei due però poté mai leggere il testo del Privilegio di fondazione (di cui c’era copia a Modica, mentre a Vittoria è documentata l’esistenza di copie delle Grazie e Franchigie, cfr. Barone). Non vide mai il Privilegio neppure Giovanni Barone, che pure fu grande divulgatore di questa presunta eredità camarinese nella sua storia di Vittoria (1950). Venuto però a conoscenza nel 1957, tramite uno studioso siracusano, che nel diploma di fondazione riaedificetur Camarina non appariva scritto in alcun luogo, tenne per sé la notizia e non ne parlò più, perché minava alla base la sua costruzione storica, ma si chiese stupito dove diavolo mai l’avessero letto i due legali palermitani Trimarchi e Matranga…
Fino a qualche anno fa si usava andare in gita in campagna il mercoledì delle Ceneri. Una stranissima usanza solo vittoriese. Ebbene, essa era un modo per ricordare la fine di una lite giudiziaria durata decenni, che aveva avuto la parola fine proprio il mercoledì delle Ceneri, il 7 marzo 1764, quando a Palermo era stata firmata la solenne transazione tra le due città in lotta. Sia Paternò che La China accreditano tale risultano all’opera intelligente e indefessa dell’arciprete don Enrico Ricca, che in onore di San Giovanni stabilì per quel giorno una solenne funzione col canto del Benedictus (onoranza che evidentemente i Vittoriesi avevano tradotto laicamente con una gita in campagna…) e fece stampare la famosa immagine di San Giovanni che si erge tra le due città con la legenda «pro gratia accordii in lite territoriali a.D. 1764)». In verità i documenti in nostro possesso ridimensionano il ruolo di don Enrico Ricca, chiamato a fare da paciere con il parroco di Chiaramonte dal Procuratore Generale della Contea colonnello don Antonio Zuñiga.
La controversia territoriale tra Vittoria e Chiaramonte era scoppiata per l’ennesima volta nel 1744, per l’esazione delle gabelle nel feudo di Bonincontro, proprietà dell’abate don Gioacchino Paternò Castello, parente del principe di Biscari. Infatti, ribellatosi ai gabellieri chiaramontani, adducendo che Bonincontro apparteneva a Vittoria e non a Chiaramonte, l’abate, d’accordo con i Giurati e il Sindaco di Vittoria, si era rivolto al Tribunale del Real Patrimonio per far dichiarare una buona volta quali fossero i confini di Boscopiano (entro i quali era Bonincontro), il cui territorio era stato assegnato a Vittoria nel 1639, però in maniera sommaria e poco precisa. Paternò Castello e gli amministratori di Vittoria chiedevano al Tribunale di riconoscere come confini di «Boscopiano, ossia la foresta di Cammarana» quelli indicati nel Quinterno dei feudi fatto redigere da Bernardo Cabrera nel 1409. In pratica si voleva porre termine una volta per tutte ad una lunghissima serie di contestazioni che duravano dal 1684. Causa della controversia erano infatti gli imprecisi confini stabiliti e la mancanza di mappe fededegne. Il territorio in cui Vittoria poteva esigere la gabella della dogana (una tassa sull’importazione-esportazione di merci), assegnatole nel 1639, era il seguente: dal un lato «…incominciando dalla carrubba di Niscima calando dalle fontane di S. Silvestro infrontando col territorio del Comiso per lo passo della Buffa tirando per il fiume di Cammerana infin sotto la sua torre ed infin a mare, e dall’altra parte dalla carrubba di Niscima, tirando per il violo del Comiso, che confina coll’Isola chiamata delli Stefani, e col Territorio del Biscari, e tira alla Cava dell’Albanello, confinando con li feghi di Durillo, ed escenti alli Macciuna [altrove: Maccuna, n.d.a.], che par che siano esclusi, e va sino a mare inchiudendo a Bosco Ritondo e lo Scaro delli Scoglitti».
Mentre però i confini con Comiso da un lato e con Biscari dall’altro erano certi -essendo le naturali cave dei due fiumi-, il limite con Chiaramonte non era affatto definito ed era approssimativamente segnato lungo l’attuale strada provinciale Comiso-Caltagirone-Grammichele (il violo del Comiso). Il territorio assegnato a Vittoria era un estesissimo triangolo che aveva il vertice in un grande carrubo nella contrada Niscima, che per la sua imponenza e notorietà doveva costituire un punto fermo per l’orientamento nella zona. Ma nel 1684 i Chiaramontani, sradicato da “ignoti” il carrubo, avevano ritenuto di mettere in discussione la deliberazione del 1639 della Corte del Patrimonio di Modica e avevano iniziato una serie di liti sulla giurisdizione di varie tenute, alcune di confine, come l’Isola degli Stefani (situata nel fondo valle del fiume Dirillo); altre in maniera assurda perché profondamente inserite nel territorio di Vittoria come la Scaletta, non disdegnando di ricorrere a qualche trucco. Addirittura nel 1714 erano riusciti a convincere lo stesso padre dell’abate don Gioacchino, il barone di Sigona don Michelangelo Paternò Castello, a dichiarare falsamente che Bonincontro era in territorio di Chiaramonte…
Imbaldanzita da questo successo, Chiaramonte continuò a promuovere via via negli anni numerosi giudizi, su contrade marginali, senza nulla ottenere. Tornò alla carica, come si è detto, nel 1744, per Bonincontro. Ma stavolta la scintilla accese un grande incendio. La prima sentenza, emessa nel 1745, fu contraria a Vittoria, le cui memorie difensive non furono nemmeno ammesse alla discussione. Fu in pratica respinta la proposta di riconoscere i confini del 1409. Lunghissimo sarebbe in questa sede rievocare tutte le vicende della controversia, cosa che abbiamo fatto a parte. Complessivamente, dal 1745 al 1762 furono emanate 4 sentenze, di cui tre a favore di Vittoria, solo la prima a favore di Chiaramonte. Il complesso sistema giudiziario dell’epoca vedeva ben tre Tribunali con funzioni similari: il Tribunale del Real Patrimonio (primo grado); la Regia Gran Corte, divisa in due sezioni Civile e Criminale (l’una d’appello alle sentenze dell’altra); il Concistoro della Sacra Regia Coscienza, diretta emanazione del Viceré: in tutto dunque tre sedi di appello. Le cause duravano decenni da un appello all’altro e si consideravano concluse (con il “perpetuo silenzio”) solo dopo tre sentenze conformi su uno stesso oggetto, ma ci si poteva appellare per una dichiarata inesatta esecuzione di sentenza e così all’infinito…Rispetto alle ricostruzioni degli storici dell’Ottocento dell’una e dell’altra città, oggi possiamo avere un quadro completo della vicenda grazie ad una copia dell’atto di transazione stipulato a Palermo il 7 marzo 1764, a me pervenuto dalla Biblioteca di Chiaramonte Gulfi, un colossale incartamento di ben 213 fogli, in cui sono contenuti tutti gli atti della vicenda e che ci consentono di ricostruirla alla perfezione.
Dopo la prima sconfitta, Vittoria cambiò i suoi legali (tra essi il vittoriese don Riccardo Toro), affidandosi a due avvocati palermitani, tali Matranga e Trimarchi, che riproposero con maggior rigore filologico e storico l’esame del famoso quinterno del 1409 (oggi purtroppo andato perduto), in cui erano descritti tutti i feudi che componevano la Contea.
I legali lo usarono per dimostrare la talietà, cioè l’identità del feudo della Foresta di Cammarana con il feudo di Bosco Piano, nel presupposto che essendo Vittoria la riedificazione di Camarina e appartenendo un tempo a Camarina la Foresta, se la Foresta era la stessa cosa che Bosco Piano, a Vittoria, erede di Camarina, spettava Bosco Piano per “diritto di territorio”.
La questione fu dapprima impostata dal punto di vista, diremmo quasi, “lessicale”, affermando che il termine «foresta in lingua latina a sentimento de’ Giuristi significa bosco largo e spazioso senza chiusura…a differenza della parola saltus, la quale significa un bosco alto di salirvi i cani, e i cacciatori per l’uso della caccia». Vocabolario alla mano, gli ineffabili giuristi di Vittoria scrivevano che «…in idioma latino foresta…vuol dire Bosco largo osia piano in idioma toscano».
Poi si entrò nel merito. Nel quinterno del 1409, relativamente alla Foresta di Cammarana, censita nel territorio di Chiaramonte, si diceva: «La foresta confina cum lu Magistratu di Claramunti [1], cum Mazzarruni [2], cum lu Baucinu [3], cum lu Biscari [4], cum lu territoriu di lu Durillu [5], cum la Favara [6], cum lu Comisu [7], et cum Boscorotundu[8]». Il “Magistrato” di Chiaramonte, cioè le terre comunali, oggi sono chiamate, per una storpiatura dialettale, Mostrazzi, mentre la Favara non è facilmente identificabile, però è nei pressi di Comiso e forse è la stessa Fonte Diana. Passandosi quindi a parlare di Boscopiano si dice: «Boscuplanu, lu quali est d’arbori di suvari, e confina di una parti cum lu Baucinu [3], e di l’autra parti cum lu Viscari [4], e di l’autra parti cunfina cu lu tirrenu di lu Durillu [5], e di l’autra parti cu la Favara [6], e di l’autra parti cu lu tirrenu di lu Comisu [7], e di l’autra parti confina cu Boscurotundu [8], e di l’autra parti cunfina cu la cuntrata di Chifali [9], e di l’autra parti cunfina cu lu tirrenu di Claramunti [1] e di l’autra parti cu Mazzarruni[2]». Sovrapponendo i confini dei due feudi (cosa che abbiamo fatto con i numeri entro parentesi quadre), ne emergeva l’assoluta identità dei confini, con una piccola differenza: Boscopiano ha un confine in più e cioè il feudo di Cifali, che non è citato tra i confini della Foresta. L’altra differenza era la registrazione come feudo esistente nel territorio di Ragusa. Rilevata dunque l’identità dei confini ne risultava non solo che la Foresta di Cammarana era la stessa cosa del feudo di Boscopiano, ma che nel 1409 si era commesso un errore di duplicazione, registrando il feudo una volta (con il nome di Foresta di Cammarana) tra quelli di Chiaramonte e un’altra volta (come Boscopiano) tra quelli di Ragusa. Assai interessante è la nota che il Boscopiano o Foresta di Cammarana che dir si voglia, ancora nel 1409 era formato da alberi di sughero, cioè era un grandissimo querceto (di cui è memoria nelle varie contrade che recano ancora oggi il nome “Sughero” e quelle anche a nome “Inferno”, dall’arabo sufer), a conferma che il nome della misteriosa “silva de suri” (cioè su[va]ri) che compare in una mappa del XIV secolo è proprio riferibile alla nostra zona.
L’esame del quinterno è contenuto nell’Allegazione in pro dell’Università di Vittoria contro l’Università di Chiaramonte, scritta dall’avvocato Giuseppe Maria Trimarchi ai primi del 1763, uno studio condotto in modo rigoroso e documentato, un capolavoro di sapienza giuridica e di grande cultura storica, che può essere considerata la prima storia in assoluto della fondazione della nostra città. Di fronte alla sterile ironia di Chiaramonte (che chiese perfino la dimostrazione che i Vittoriesi fossero discendenti dei Camarinesi…) e che per negare i diritti di Vittoria si spinse fino a considerare nulli documenti fondamentali per la storia della Contea (il Quinterno del 1409 appunto), Vittoria seppe documentare le sue richieste dimostrando che:
- il Feudo di Boscopiano e la Foresta di Cammarana erano la stessa cosa (avevano infatti gli stessi confini, come si è visto sopra);
- il feudo era indipendente e nullius, cioè mai sottoposto al possesso territoriale da parte di Chiaramonte;
- Vittoria, costruita nel suo interno, era giuridicamente la naturale padrona di quel territorio, e comunque:
- ne aveva maturato il diritto grazie all’effettivo possesso (dal 1639 in poi infatti vi aveva usato giurisdizione, pagato su di esso le tasse al re, aveva riportato per esso numerose sentenze a suo favore). Queste furono affermazioni dimostrate da Vittoria con documenti alla mano, cui fu aggiunta l’affermazione di un ulteriore, maggiore, diritto derivante dall’essere Vittoria la riedificazione, e quindi l’erede “patrimoniale”, di Camarina.
Chiaramonte oppose solo che la tale tenuta o la tal altra era in territorio di Chiaramonte una volta, prima della fondazione di Vittoria, appunto…
Solo in merito alla “eredità camarinese”, Chiaramonte aveva ragione a dire che era una «nuda asserzione», da cui scaturivano «temerarie induzioni» (Nicosia), ma non riuscì a smontare l’affermazione assiomatica del riaedificetur Camarina, che non sta scritto in nessuna parte e che solo di passaggio e con parecchia esitazione l’estensore della memoria attribuisce al re Filippo III, nella sua ratifica del Privilegio, avvenuta il 31 dicembre 1606. Vittoria diceva che al re si doveva la volontà di “riedificare Camarina”, avendo usato nel Privilegio le parole «diamo licenza e plenaria potestà di poter riedificare o di nuovo edificare, o di fare abitare il detto feudo di Vittoria». Solo su quel ri-edificare è basato l’azzardo della difesa vittoriese, che su tale assioma costruì un fortunato sillogismo:
- Boscopiano è l’antica foresta di Cammarana;
- la foresta di Cammarana o Boscopiano apparteneva un tempo a Camarina;
- Vittoria è stata costruita in sostituzione di Camarina, dunque:
- Boscopiano è di Vittoria.
Tale assiomatica, preventiva, indimostrata e indimostrabile verità è solo una parte, in effetti la più debole, del complesso della difesa vittoriese, ma l’insieme della difesa ebbe la capacità di convincere i giudici. I quali infatti respinsero la tesi chiaramontana basata sull’inapplicabilità ai Vittoriesi dell’istituto giuridico previsto dal diritto romano del postliminio, che avrebbe dovuto essere negato a Vittoria perchè Camarina era stata distrutta dai Romani per punizione della sua ribellione, e i Vittoriesi, non essendo suoi discendenti, non potevano in nessun modo essere reintegrati nei possessi territoriali di cui quella città aveva goduto.
I difensori di Vittoria invece li persuasero che la causa andava esitata in base al concetto di recupera di diritti appartenenti all’antica città di Camarina, poiché Vittoria, pur non costruita nello stesso sito, ma sempre nell’ambito del suo territorio, doveva essere ammessa a goderne la proprietà in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza medievale «una città distrutta e poi ricostruita riacquista i suoi antichi privilegi» (nel nostro caso il territorio), a due condizioni:
- distruzione ad opera di nemici senza colpa degli abitanti;
- ricostruzione col permesso del principe.
Mentre nel nostro caso la fondazione di Vittoria rientrava nella seconda condizione (ricostruzione voluta dal sovrano), i Chiaramontani affermavano che Camarina era stata distrutta per essersi ribellata ai Romani nel 258 a.C. Ebbene, merito straordinario di Trimarchi è avere sin da allora smentito con le fonti storiche in mano (seguendo in ciò Polibio) che Camarina fosse mai stata completamente distrutta dai Romani, come invece la storiografia ottocentesca stabilirà imperiosamente, ignorando volutamente una fonte seria come Polibio.
Non essendo mai stata distrutta Camarina completamente dai Romani, ma solo decaduta per «l’ingiuria dei tempi» nel I secolo d.C., come attesta il geografo Strabone, Vittoria, «surrogata» all’antica città, aveva tutto il diritto di recuperarne il territorio, secondo gli antichi confini del 1409, da Mazzarrone a Biscari al Dirillo alla Favara a Comiso a Bosco Rotondo alle terre un tempo del Magistrato di Chiaramonte (le odierne contrade di Piraino, Fontanazza, Pedalino, Favarazzi o Favaragghi, Mostrazzi e Monacazza) e di nuovo a Mazzarrone: nell’ambito di questo territorio era Bonincontro, molto all’interno rispetto al confine dell’antico Magistrato. La sentenza del 2 marzo 1763 accolse pienamente queste tesi, che definivano i confini e inglobavano a Vittoria i cosiddetti Macconi, esclusi nel 1639 (oggi invece di Macconi di Dirillo appartengono ad Acate). Chiaramonte non si arrese: prima riuscì a farsi assegnare dallo stesso Concistoro (che aveva emanato la sentenza del 2 marzo) Bosco Rotondo e Baucino, con la motivazione che essendo confini del Boscopiano, ne erano al di fuori, quindi appartenevano a Chiaramonte. Ci volle un’altra sentenza il 19 luglio 1763 per ridare questi due feudi a Vittoria.
Poi la cittadina montana tentò di annullare gli effetti economici della sentenza, chiedendo che le gabelle dei rivelanti forestieri nelle terre contese si continuassero a pagare a lei fino al nuovo censimento, ottenendo un diniego dalla Deputazione del Regno (il 20 settembre 1763). Visti svanire nel nulla i suoi tentativi, voleva di nuovo riprendere la questione della carrubba di Niscima, ma per la mediazione di Zuñiga, Ricca e Melfi si arrivò alla transazione, solennemente stipulata il 7 marzo 1764. Battutasi come una leonessa, Chiaramonte dovette prendere atto della inutilità dei suoi tentativi di rimettere in discussione un assetto territoriale più che centenario. Erede o no di Camarina, Vittoria aveva il merito di essere cresciuta economicamente in maniera impetuosa, sconvolgendo il tranquillo e arcaico paesaggio della parte occidentale della Contea. Padre Samuele Nicosia ammette infatti che era stata la forza economica della città della pianura a farle vincere sin dall’inizio la guerra. Le ricerche sui riveli del 1714 e del 1748 fotografano compiutamente l’energia e l’immensa forza economica delle campagne di Vittoria, vero e proprio mare sterminato di vigne, per quasi 3000 ettari….
Infine, due parole sull’accordo. Simbolizzato dalla bella immagine di San Giovanni, che si erge tra le due città, esso si basa sulla trazzera che già nel 1639, la Corte Patrimoniale aveva preso come confine («da Niscima tirando per il violo del Comiso, che confina coll’Isola chiamata delli Stefani», in fondo alla valle del Dirillo e del fiume Mazzarrone): da una parte Vittoria con Boscopiano e Bosco Rotondo, dall’altra Chiaramonte con le terre del Magistrato (da Bosco Rotondo al Mazzarrone). C’erano voluti cento e più anni per capire che quel confine naturale (l’antica strada che da Comiso conduceva a Mazzarrone) e non i nomi delle contrade, era l’unica vera linea divisoria tra le due città.
Ma da allora, la classe dirigente vittoriese, uscita vincitrice dal cimento con Chiaramonte (anche se a mezzo di una saggia transazione dietro la quale stanno sei sentenze a favore di Vittoria e solo una per Chiaramonte), grazie anche all’uso intelligente e spregiudicato della storia antica condensò nel motto riaedificetur Camerina la vicenda della nascita di Vittoria e per questo cominciò ad usare, tra fine Settecento e primi dell’Ottocento l’aggiunta post Camerinam all’usuale Victoria pulchra civitas. Un caso fra i tanti nella storia, in cui vicende più o meno grandi si condensano in poche parole.
Testimoniano la nuova temperie culturale le decisioni degli amministratori dell’epoca, che nel 1820 intitolarono Camerina l’attuale Piazza del Popolo, chiamarono con i nomi dei due fondatori di Camarina le attuali vie Garibaldi (Dascòne) e Bixio (Menelao, storpiatura di Menecolo). Inoltre chiamarono la strada d’accesso alla chiesetta di Santa Rosalia (attuale via San Martino) via Ipperia (da Iperea, nome leggendario di una città dei Feaci, identificata con Camarina, secondo Cluverio), nome transitato nel 1864 alla parte finale della scesa dei due mulini, oggi via Ipperia. La fonte di questa cultura classicheggiante fu l’erudizione settecentesca dell’abate Vito Amico, che pubblicò nel 1757 il suo Lexicon Topographicum. Ma se allo stemma tradizionale di Vittoria pulchra civitas fu aggiunto post Camerinam non è certo dovuto alla cultura libresca di qualche colto sindaco dell’epoca (in particolare Filipponeri Leni), né all’interesse che specie dopo le scoperte di Pompei ed Ercolano nel 1738 si era diffuso in entrambi i regni borbonici di Napoli e Sicilia. Né ci sembra di poterlo addebitare alla visita a Camarina di Jean Baptiste Houel né al saccheggio che delle necropoli di Camarina fece Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari: a mio avviso si trattò solo dell’esito della lite territoriale…
NOTE
1] La forma latina esatta sarebbe reaedificetur, non riaedificetur, come generalmente si dice.