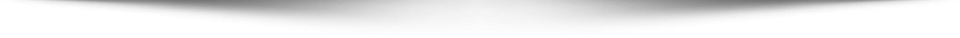L’Oratorio della Congregazione del SS.mo Crocefisso e il Venerdì Santo.
Altre opere d’arte sono custodite nell’Oratorio della Congregazione, dal 1966 in locali avuti in permuta dalla Basilica in cambio dell’antico Oratorio (cappella del SS.mo Crocifisso, a sinistra dell’Altare Maggiore). Tra esse sono conservati:
- lo stendardo ricamato in argento (probabilmente del Settecento);
- gruppo in cartapesta di scuola leccese di Gesù Crocifisso con S. Giovanni Evangelista e Addolorata dell’Ottocento;
- piccolo Crocifisso ligneo dell’Ottocento;
- scatola di latta per raccogliere offerte, già appartenuta alla Congregazione del SS. Sacramento con placca in argento che raffigura un ostensorio;
- coperta funebre in velluto nero ricamata in oro risalente ai primi del Novecento.
Altri pezzi in argento ed il manto dell’Addolorata sono conservati da vari confratelli (Palmeri).
Alla Congregazione del SS.mo Crocifisso è legata la più antica tradizione vittoriese, quella del Venerdì Santo, su cui scrisse un bel saggio il prof. Angelo Alfieri1.
Sulla nascita della Congregazione del SS.mo Crocifisso, La China (pag. 215) riferisce che nel 1644 il parroco don Vincenzo Sesti aveva chiamato «una missione di Gesuiti, con a capo il P. Luigi Lanuzza, che fu nel contempo istitutore della Congregazione del Crocifisso nella prima Chiesa Madre, e l’istitutore della Congregazione del Rosario nella Chiesa di San Vito»2. La venuta di questa prima missione lasciò tracce profonde nella religiosità popolare vittoriese, al punto da far nascere la tradizione delle Sacre Rappresentazioni, testimoniate da La China sin dal 1669 e che dagli anni ’80 dell’Ottocento ebbero nel testo del marchese Alfonso Ricca il loro copione colto e immodificabile.
Emanuele Ingrao3 nel 1984 pubblicò un breve saggio sulla storia della Congregazione Secreta de’ 33, in appendice alla quale sono riportate le regole del Lanuza, di chiaro impianto gesuitico, con una minuta serie di prescrizioni. Queste regole della Congregazione Secreta de’ 33 ad honore della Passione e Cinque Piaghe di N.S. e della Beatissima Vergine Addolorata fondata dal R.P. Luigi Lanuzza della Compagnia di Gesù alli 20 di Maggio 1644 nella Matrice Chiesa della Città di Vittoria & renovata da doi Padri della Medema Compagnia a 14 di Giugno del 1657 furono ratificate a Siracusa nel 1660. Dal testo possiamo desumere un elenco di festività connesse al culto della Madonna (Purificazione: 2 febbraio; Nunciazione: 25 marzo; Assunzione: 15 agosto; Natività: 8 settembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre) che dovevano celebrarsi a Vittoria, insieme con il Carnevale, citato nelle Regole come occasione di peccato da evitare e strettamente connesso con l’inizio della Quaresima. Inoltre si disponeva che:
«XII. Ogn’anno il Venerdì Santo faranno una solenne processione coll’Imagine di Cristo Nostro Signore morto nel lenzuolo ch’l prenderanno dal Calvario, o d’altro luogo secondo permetterà il tempo, cantandosi il Miserere, o altri salmi, e devozioni funebri, procedendo tutti li Fratelli con suoi sacchi mortificati in diversi modi, e termineranno alla Madre Chiesa dove si prenderà il perdono, baciando li piedi del Medemo Signor morto».
«XIII. Ogni Venerdì di Marzo la sera anderanno detti Fratelli in processione a visitare il Calvario fuori la Città, e torneranno alla Madre Chiesa, dove starà esposto tutti quei giorni il SS. Sacramento…».
Sembrerebbe dunque che la processione del Venerdì Santo ad opera dei confrati della Congregazione si sia innestata su una processione solita ab antiquo del Clero vittoriese al Calvario, allora nella zona dell’attuale chiesa di San Francesco di Paola4. Ciò significa che il clero vittoriese (e si presume anche i fedeli) usava celebrare il Venerdì Santo recandosi al Calvario allora esistente in contrada Croce -oggi San Francesco di Paola- registrata nei riveli sin dal 1623); la missione di Lanuza avrebbe avuto il merito di creare una Congregazione che aveva tra i suoi compiti fissi di accompagnare quella solita processione del clero portando un’«Imagine di Cristo Nostro Signore morto nel lenzuolo ch’l prenderanno dal Calvario» azione che a rifletterci bene contiene già in nuce l’idea e il titolo stesso di quei famosi dialoghi La scesa della croce che secondo La China si recitarono sin dal 1669 «come risulta dalla prima licenza concessa ai Confrati del Crocifisso da Monsignor Vescovo di Siracusa, in data 31 marzo 1669».
Ai capitoli della regola del 1660 furono aggiunti altri nel 1676 (ratificati del 1683), in cui la Congregazione Secreta de’ 33 si trasforma in Congregazione secreta del SS. Crocifisso della Madre Chiesa della Città di Vittoria sotto titolo di San Gio: Battista, che accentua l’aspetto di partecipazione al momento del trapasso di ogni singolo confrate. Purtroppo non sappiamo nulla del contenuto dei versi della Scesa della Croce, anche se nella poesia popolare vittoriese si trova qualche traccia di canti religiosi legati alla Settimana Santa5. Traccia importante della processione è nel bilancio della Congregazione, presentato nel 1748, laddove, tra le spese, si cita quella della cera dei fani.
Infine, non possiamo dimenticare, tra le opere d’arte connesse alla tradizione, il cosiddetto cataletto il manto dell’Addolorata e l’urna.
Il cataletto è il letto funebre su cui viene portato il Cristo nella processione mattutina, realizzato nel Novecento in sostituzione di uno più antico; i cuscini in velluto nero e ricamati in oro furono offerti dalla sig.ra Agata Rizza Jacono ved. Malerba (figlia di don Evangelista Rizza), ai primi del Novecento (Palmeri). Si è già detto che la statua in cartapesta e quella in legno dell’Addolorata sono custodite in una nicchia della cappella del SS.mo Crocifisso a San Giovanni; il manto fu fatto fare a fine Ottocento dalla baronessa Concetta Ricca Jacono, moglie di Francesco Leni di Spadafora (sindaco dal 1892 al 1895) e restaurato negli anni Cinquanta dalla signora Rosa Galbo Calarco, che lo arricchì ulteriormente (Palmeri). Il piedistallo su cui viene trasportata l’Addolorata fu fatto nei primi anni ’80 dalla ditta Giallongo, con disegni del prof. Arturo Barbante. L’urna che dopo le Parti riconduce il Cristo morto a San Giovanni fu fatta costruire nel 1834 a Palermo dal barone don Gioacchino Ricca per conto della Congregazione e dopo alquante vicissitudini fu ottimamente restaurata6 negli anni Ottanta del Novecento. Nell’Oratorio è custodito infine un quadro raffigurante padre Aloisio Lanuza, fatto fare nel 1819 da don Francesco Maria La China. Il dipinto è in buone condizioni e reca la seguente scritta: «hanc primam sodalitatem sub titulo SSmi Salvatoris in Cruce Confixi, et Deipare Virginis Doloris gladio vulnerate cum maximo animarum lucro erexit anno Domini 1644».
NOTE
1]Angelo Alfieri, Sacre rappresentazioni a Vittoria. Storia e testi, Utopia Edizioni 1988.
2] Padre Luigi La Nuza (o Lanuza), nato a Licata nel 1591, entrato nella Compagnia di Gesù nel 1608, divenuto professore di retorica, «dedicò tutte le sue forze alle Sacre Missioni.. Nelle prediche al popolo fu straordinario: per ascoltarlo da ogni parte confluivano enormi schiere di persone: tanto che neppure le chiese più grandi potevano contenere la folla. Per cui per accontentare tutti, era costretto a parlare in grandissime piazze e in spazi aperti della campagna e non una sola volta a Palermo parlò a 25.000 persone. Portò la sua predicazione in tutte le città della Sicilia e delle isole vicine…: per questo con voce unanime fu acclamato Apostolo della Sicilia». Così lo dipinge il canonico Antonino Mongitore nella sua Bibliotheca Sicula, aggiungendo con linguaggio partecipe notizie di miracoli, profezie e della sua morte avvenuta nel 1656, dando infine i titoli delle sue pubblicazioni, tra cui in spagnolo Remedio precioso contra la pestilencia del pecado mortal (Palermo 1640 Editore Bua), tradotto poi in italiano.
3] Emanuele Ingrao, Cenni storici della Congregazione del SS. Crocifisso di Vittoria, Rotaract Club Vittoria 1984.
4]Lo deduciamo dalla deliberazione di assegnazione della terra (3 marzo 1679) per la costruzione della nuova chiesa di San Francesco, in cui si assegnarono 18 tumoli in contrada Cozzo del Calvario.
5]Giovanni Consolino, Poesia popolare raccolta a Vittoria, pag. 283
6] A cura delle ditte Giallongo di Vittoria e Jozzia di Ragusa.